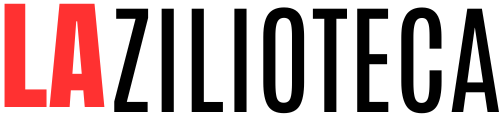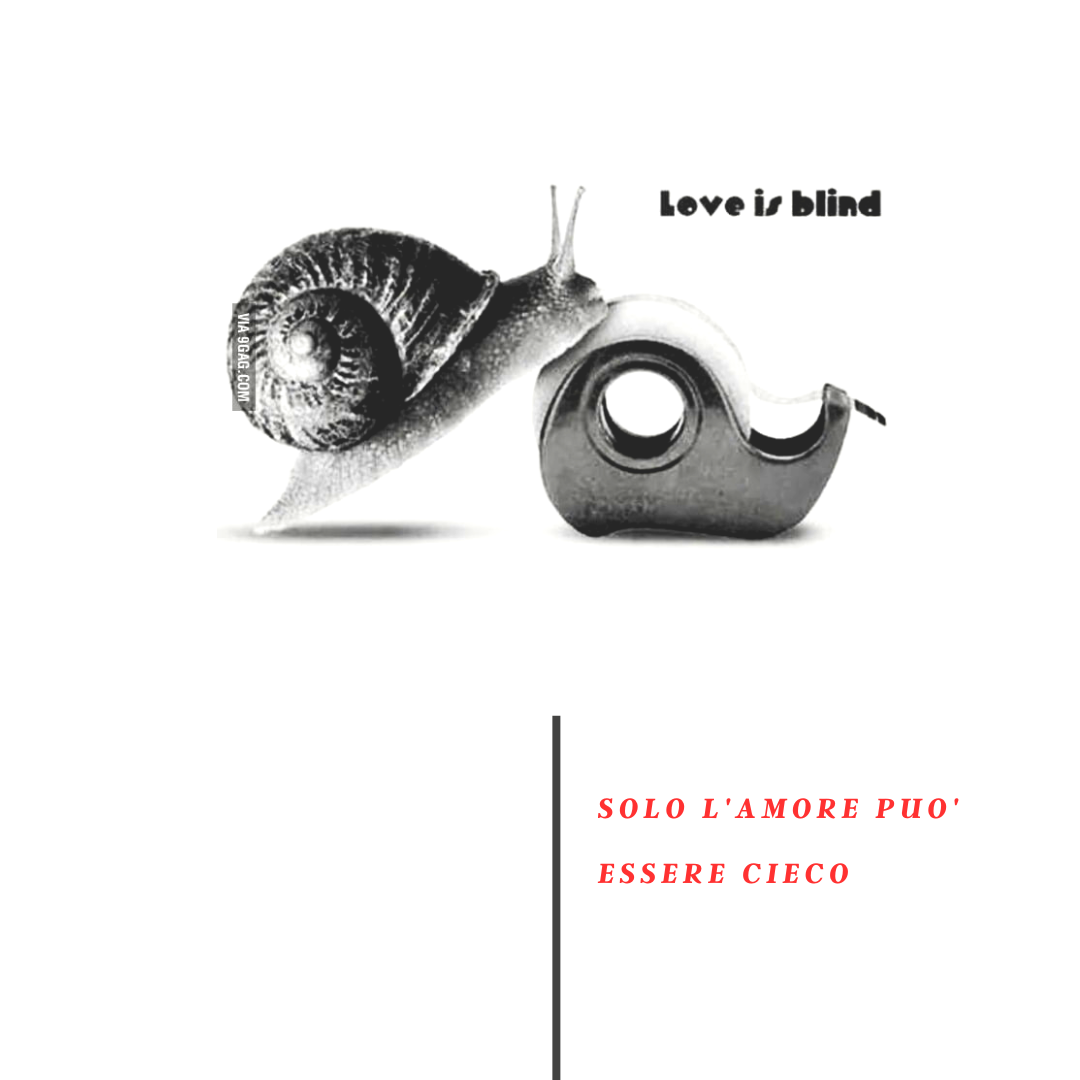Dossier Emozioni — Un’indagine tra psicologia, cultura pop e neurochimica
Da Shakespeare a Netflix, dalla dopamina alle relazioni tossiche: il detto “l’amore è cieco” è più attuale che mai. Ma è solo un modo per giustificare ciò che non vogliamo vedere? Oppure racconta qualcosa di profondo su come scegliamo chi amare?
Di fronte alle contraddizioni dei sentimenti, ci rifugiamo spesso in questa frase: “l’amore è cieco”. Un detto che ci consola, ci giustifica, ci unisce. Ma è davvero così? E se lo fosse, è un difetto del cuore o un inganno della mente?
1. Amare senza vedere (o vedere senza capire)
L’amore è cieco. Quattro parole che sentiamo ovunque. Nei romanzi, nelle canzoni, nei bar con gli amici, nelle storie finite male e perfino in tribunale, quando si tenta di spiegare l’inspiegabile. È un’espressione universale, immediata, potente. Ma anche piena di contraddizioni.
Perché se da un lato ci consola — ci fa sentire normali quando sbagliamo per amore — dall’altro è un’ammissione implicita: quando amiamo, non vediamo le cose come sono. E se l’amore ci acceca, chi guida davvero le nostre scelte?
2. Una frase che viene da lontano
L’origine del detto affonda nei secoli. I Greci antichi dipingevano Eros bendato, a significare la sua imprevedibilità. I Latini lo chiamavano “Cupiditas”, desiderio, impulso, bisogno non controllabile. In epoca rinascimentale, Shakespeare lo consacrò nella cultura popolare con una delle sue frasi più citate:
“Love is blind, and lovers cannot see the pretty follies that themselves commit” — L’amore è cieco, e gli amanti non vedono le sciocchezze che compiono.
Ma la forza di questo modo di dire è che continua ad adattarsi. Cambiano i contesti, ma non il senso. Siamo nel 2025, circondati da app di dating, algoritmi e love coach, eppure, chi di noi non ha detto almeno una volta: “Mi sa che l’amore mi ha reso cieco/a”?
3. La scienza ci guarda dentro (e ci trova bendati)
L’amore, per la psicologia e le neuroscienze, non è un sentimento semplice. È un mix chimico, cognitivo, emotivo e culturale. Quando ci innamoriamo, il nostro cervello è letteralmente drogato: rilascia dopamina (piacere), ossitocina (legame), serotonina (felicità), adrenalina (eccitazione). Questo cocktail ci fa stare bene, ma, ci altera anche la percezione.
Uno studio del 2005 pubblicato su The Journal of Neurophysiology ha osservato il cervello di persone innamorate con una risonanza magnetica. Risultato? Alcune aree legate al giudizio critico e alla valutazione oggettiva si disattivano. È come se il cervello dicesse: “Fidati, è amore. Non pensare troppo.”
Il paradosso è che proprio mentre pensiamo di aver trovato la persona più adatta, siamo nel nostro momento di maggiore vulnerabilità cognitiva. Non vediamo i difetti, idealizziamo, neghiamo i segnali d’allarme. E quando qualcuno ci fa notare qualcosa (“ma non ti sembra un po’ strano che sparisca per giorni?”), lo liquidiamo con: “Tu non lo conosci come lo conosco io…” L’amore è cieco.
4. Quando l’amore è davvero cieco: casi, esperienze, paradossi
Pensiamo a esempi famosi: Ted Bundy, uno dei più noti serial killer americani, ricevette lettere d’amore in carcere da decine di donne. Alcune erano convinte della sua innocenza, altre dicevano di vedere in lui “un uomo profondo, incompreso, ferito dalla vita”. L’amore, in quel caso, non solo era cieco: era completamente scollegato dalla realtà.
Oppure pensiamo a vicende comuni: persone che restano in relazioni tossiche per anni, incapaci di vedere l’evidenza. In psicologia si parla di dissonanza cognitiva: quando i fatti non combaciano con le emozioni, scegliamo di credere alle emozioni, anche se ci fanno del male.
È la dinamica dietro molte relazioni disfunzionali: partner narcisisti, manipolatori, bugiardi. Eppure, l’altro/a non riesce a lasciarli. Perché? Perché “l’amore non guarda in faccia nessuno”. E in certi casi, purtroppo, questo è tragicamente vero.
5. L’amore e la cultura pop: da Shakespeare a Love Is Blind
Se Shakespeare ha dato nobiltà letteraria alla cecità amorosa, oggi la cultura pop la trasforma in spettacolo. Prendiamo la serie Netflix Love is blind: uomini e donne si conoscono in stanze separate, senza mai vedersi. Parlano, si emozionano, si “innamorano” e si chiedono in moglie o marito prima di vedersi in faccia. Il messaggio è chiaro: l’amore, se è vero, prescinde dall’aspetto.
Ma poi cosa succede? Quando finalmente si incontrano, le reazioni sono un misto di stupore, tensione, a volte delusione. Alcune coppie reggono. Altre crollano dopo un paio di giorni.
Perché? Perché l’amore cieco funziona finché resta nel buio dell’immaginazione. Appena la luce della realtà si accende, iniziano i compromessi. E non sempre siamo disposti a farli.
Anche il cinema ha sempre giocato su questo concetto. Da Shallow hal a Il diario di Bridget Jones, fino a Her — dove il protagonista si innamora di un’intelligenza artificiale — l’idea che l’amore possa ignorare la realtà esterna è un tema ricorrente. Ci affascina, ci illude, ci commuove. Ma forse ci serve anche a perdonare le nostre scelte discutibili.
6. L’altra faccia della cecità: vedere troppo poco, amare troppo presto
La cecità amorosa non è solo non vedere i difetti. È anche vedere troppo poco e troppo in fretta.
Viviamo nell’era delle relazioni lampo, delle “vibes” su Tinder, delle bio scritte con ironia, ma anche con strategie di marketing. In questo mondo accelerato, ci basta un paio di frasi e qualche emoji per sentirci “connessi”. Il problema? Costruiamo castelli emotivi sulla sabbia della proiezione.
Quello che chiamiamo “amore a prima vista” è spesso una proiezione potentissima di ciò che vorremmo trovare, non di ciò che realmente c’è. Come spiega lo psicologo Aron Beck, uno dei padri della terapia cognitiva, l’innamoramento può essere una forma di “distorsione cognitiva”, dove applichiamo schemi interni alla realtà esterna. In pratica: ci innamoriamo dell’idea che abbiamo dell’altro, non della persona in sé.
Non a caso, molti innamoramenti intensi finiscono nel giro di settimane, appena la fantasia si scontra con la verità. È una forma di cecità rapida, effimera, ma non meno potente.
7. Ma l’amore vero deve vedere
A questo punto, una domanda sorge spontanea: ma allora l’amore autentico non è cieco?
La risposta, per quanto meno romantica, è: no, non dovrebbe esserlo.
L’amore che resiste, che cresce, che costruisce è quello che vede benissimo. Vede i difetti, le fragilità, le incongruenze. E nonostante tutto, sceglie di restare. In psicologia relazionale si parla di “amore maturo”: un sentimento che nasce dalla conoscenza reciproca, non dall’idealizzazione. Non è il colpo di fulmine, ma il passo deciso. Non è la perfezione immaginata, ma l’imperfezione accettata.
Lo psicanalista Otto Kernberg distingue tra innamoramento (fase iniziale, passionale, soggettiva) e amore oggettuale (fase evoluta, basata su realtà e scelta). Nella seconda fase, la cecità si dissolve e restano la cura, il rispetto, la fiducia. È lì che l’amore smette di essere cieco e inizia a vedere — davvero.
8. Conclusione: occhi aperti, cuore acceso
“L’amore è cieco” Sicuramente è una frase che funziona, perché ci libera dal peso delle scelte sbagliate. Ma è anche un’arma a doppio taglio. Può diventare una scusa, un alibi, un paraocchi. Per questo è importante chiederci: quanto vediamo davvero, quando amiamo? E quanto scegliamo di non vedere?
In fin dei conti, amare è un atto di coraggio: guardare l’altro con occhi aperti, e continuare a scegliere lui o lei ogni giorno. È facile idealizzare, difficile accettare. Ma è lì nel mezzo della realtà, dei difetti, delle incomprensioni che l’amore smette di essere cieco. E diventa vero.